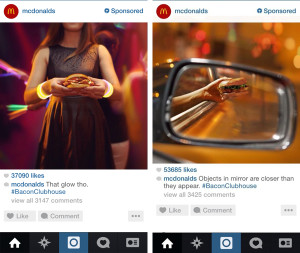
E se i social media dei brand fossero una “bolla”? Secondo Douglas Holt, forse il maggior teorico della “innovazione culturale”, che ha ripreso il tema a lui caro sul numero di marzo della Harvard Business Review, siamo già oltre la fase dell’interrogativo: la vanità dell’illusione coltivata dai grandi brand, quella che scavalcare i media e relazionarsi direttamente con i clienti con approcci tipici dell’intrattenimento popolare (in sostanza riproponendo la minestra riscaldata già servita sui mass media) sarebbe ormai agli atti. Per smarcarsi dai media tradizionali e sfruttare la viralità del digitale “è nata la corsa ai grandi contenuti di marca. Ma i loro paladini non mettevano in conto una nuova concorrenza, che adesso non veniva più dai colossi dei media ma dalla folla”. Se un tempo, scrive Holt, le imprese e i mass media fungevano da intermediari dell’innovazione culturale che proveniva dai margini della società in opposizione alle convenzioni tradizionali, oggi i social media rendono interconnesse le comunità: è l’esplosione della crowdculture. “Oggi troverete una sottocultura fiorente intorno a qualunque argomento: il caffè espresso, la fine del Sogno Americano, la stampa 3D, i film di animazione giapponesi, il birdwatching, il barbecue. In passato i membri di queste sottoculture dovevano riunirsi fisicamente e avevano mezzi molto limitati per comunicare collettivamente, riviste specializzate e successivamente i primi gruppi di utilizzatori che si formavano sulla Rete e i meet-up. I social media hanno ampliato e democratizzato queste sottoculture. Con pochi click potete mettervi al centro di qualunque sottocultura…Oggi milioni di agili imprenditori culturali si riuniscono on line per affinare le proprie tecniche, scambiarsi idee, mettere a punto i contenuti e competere per la produzione di grandi successi”. Il succo è che i numeri dei brand sono ridicoli a fronte di quelli di tanti carneadi venuti fuori dal nulla. Il canale You Tume di McDonald’s è al n. 9914 della classifica comandata da un tale PewDiePie, uno svedese che posta filmati amatoriali con dei commenti stizziti fuori campo sui videogame e che sta facendo a che con una spesa quasi inesistente 200 volte le visualizzazioni del grandi brand. Il sito della Coca Cola non è nemmeno tra i primi 100.000 degli Stati Uniti. I social media degli attori, dei cantanti o dei calciatori fanno numeri che i brand non vedono neppure col cannocchiale: d’altronde “non dovrebbe essere una sorpresa. Interagire con un entertainer che si ama non è come interagire con un brand di autonoleggi o di succo d’arancia. L’idea che i consumatori possano parlare di Corona o di Coors nello stesso modo in cui discutono del talento di Messi o Ronaldo è semplicemente assurda”.
Holt sostiene che il boom dell’agricoltura biologica, ad esempio, nasce come successo di una crowdculture che alcune aziende sono state pronte a cavalcare (un esempio è Chipotle, che ha avuto successo perché si è inserita in questa crowdculture e ne ha sposato la causa). L’indicazione finale è che, prendendo di mira ideologie innovative che emergono dalla crowdculture, i brand possono affermare un punto di vista visibile nell’ambiente mediatico, saturo di messaggi.
Buona parte della tesi è del tutto condivisibile: però mettere sullo stesso piano i fan di un brand e quelli di uno che urla e gesticola davanti a una webcam sorvola sul fatto che la seconda attività, salvo pochissime eccezioni, non rende nulla. E’ vero che i brand non hanno sul web una popolarità pari alla loro fama e alle aspettative ma è vero pure che i loro fan hanno un peso differente e che comunque il punto critico è l’incontro tra la diffusione sul web e il rendimento economico che ne può derivare.
La lezione principale che le aziende possono ricavare mi sembra piuttosto questa: è più interessante (per il pubblico potenziale e quindi indirettamente anche per le aziende) parlare di argomenti che le persone condividono che non del brand. E se poi è centrato su se stessi, il discorso sull’azienda è più coinvolgente del discorso sul brand: perchè l’azienda è reale, proprio come Messi e Ronaldo (o quasi).
La rivelazione che in definitiva può suonare sconcertante è: le aziende, anche quelle grandi, non hanno imparato a usare i social media. Li hanno impiegati al modo adolescenziale che si potrebbe riassumere in : parliamo tanto di me (anzi, del mio brand).
Con Anima in Corporation suggeriamo a ciascuna azienda di cosa sarebbe opportuno che parlasse. Voi di cosa parlate? Volete sapere come potremmo aiutare che la vostra azienda si distingua sui social media?
Compilate il form indicando il periodo in cui voreste essere contattati.
